Erano i tempi della noia borghese
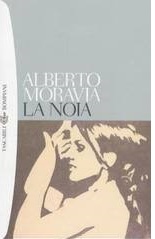 Perché Moravia. Perché Moravia.
Cammino a piedi, lungo la strada che si affaccia sul fiume e intravedo un piccolo slargo, il palo giallo di un semaforo piantato sul cemento, qualche alberello in un’aiuola recintata da uno steccato di legno, e poi giro l’angolo del palazzo.
Inizio a seguire il filo di bordo rosso del balcone stondato che sporge al secondo piano dalla facciata. Arrivo così davanti al portone in legno, è il primo della via, con piccoli rettangoli di vetro disposti in linea orizzontale. Al centro, su ciascuna delle due ante, c’è un pomello d’acciaio rotondo.
È uno di quei primi pomeriggi scuri di novembre quando arrivo al civico numero 1 di Lungotevere della Vittoria.
Sono sotto la casa di Alberto Moravia, tenendo in mano il romanzo della Bompiani, “La noia”.
Entro rapidamente nell’ascensore assieme a una donna di sessant’anni circa, con il viso lungo e il mento appuntito. Sta accanto a me, dritta, in perfetto equilibrio nonostante lo stridio delle corde dell’ascensore e i piccoli sobbalzi. Tiene stretta la sua borsa, nera e senza bretella, ha il palmo della mano sinistra ricurvo come avesse un registro di classe. Non parla, solo un piccolo cenno con il capo, eppure, dallo specchio, con occhi guizzanti sotto gli occhiali di tartaruga, sbircia il colletto celeste della mia camicia, il cuoio delle scarpe nere, l’inclinazione del busto.
Le manca solo il gessetto per una lavagna.
Allungo il braccio ruotando leggermente la spalla e apro la porta dell’ascensore, facendo attenzione a non sfiorarla con il dorso della mano.
Quando mi passa davanti intravedo la punta del naso spigoloso, il collo leggermente allungato che esce da un cappotto grigio, la pelle bianchissima, i capelli color mogano con una striatura di grigio e un velo di rossetto sulle labbra.
Passa prima lei, io la seguo a poca distanza mentre suona il campanello della porta.
Siamo qui per lo stesso motivo.
Se l’oggetto del romanzo diventa la noia, l’inversione rapida del rapporto di relatività tra personaggio e cose svolge il ruolo d’innesco incendiario, un elemento nuovo nella scena del dramma esistenziale umano, la tela che si lacera, la coscienza di sé che esplode e mette in luce il dualismo oscillante tra mente e linguaggio, per tratteggiarne le cause, la fenomenologia.
Per un attimo la testa è altrove.
Avevo letto il primo capitolo due giorni prima, seduto in un autobus mentre tornavo dalla stazione Termini. Accanto a me c’era una signora peruviana, e di fronte un giovane ragazzo con un casco di capelli ricci scuri che armeggiava con l’auricolare collegato al suo iPhone. Avevo visto le sue labbra muoversi mimando le parole di una canzone, con le dita che tamburellavano sulle ginocchia. Giocava con la musica, fino a quando ha estratto un pezzo di carta. E poi ha cominciato a scrivere. Muoveva la testa a ogni parola, su e giù, alzando ogni tanto lo sguardo, ruotando il collo per sciogliere la muscolatura, eppure la penna continuava a scorrere. Freneticamente. In due minuti aveva riempito una pagina. E, alla fine, non mi aveva visto mentre gli passavo accanto per scendere. Avrà avuto massimo quindici anni quel ragazzo dalle ossa lunghe che componeva musica.
Entro a casa Moravia, la donna ha allungato il passo. Vedo ormai solo le sue spalle.
Oltrepasso il corridoio, cammino lungo il parquet scricchiolante, con piccoli scaffali bianchi ricolmi di libri. Rallento, per guardare il dossetto di un volume con la copertina blu, rigida, dentro la libreria, e vedo il numero di catalogo stampato sull’etichetta rettangolare.
Da un momento all’altro mi aspetto che Moravia sbuchi all’improvviso, uscendo dal suo studio. La porta del salone si apre, lui entra con lo sguardo burbero, la camminata storta, la voce squillante, e il bastone.
“Dunque, pensai, finiremo così: ai due capi di un filo telefonico senza neppure vederci”.
C’è un racconto alla fine del suo romanzo proprio con queste parole, si chiama “Valérie”. Mentre cerco un posto, svicolando tra le sedie disposte in linea orizzontale, una accanto all’altra, ripenso a Moravia che telefonava spesso ai suoi amici, nelle prime ore del mattino.
Forse il telefono era proprio in un angolo del salone, e mi cade lo sguardo sul piccolo comodino.
Ma la prova che Moravia sia davvero lì, è il ritratto di Guttuso sopra il divano centrale, tra le maschere africane appese alla parete. È carne viva, sta seduto sulla poltrona, indossa ancora quel golf rosso acceso, la sua giacca blu con le pieghe alle maniche, e ha il gomito sinistro poggiato alla spalliera. Non è assorto, ci guarda di sbieco. Ha le mani grosse, dure come il ferro, con le nocche sporgenti. Sono le stesse mani con cui aveva scritto “Gli indifferenti” tra le lenzuola del letto macchiate d’inchiostro, ai tempi della tubercolosi ossea e della degenza a Bressanone.
Il camino dentro il salotto è spento.
Qualche mese prima avevo visto un'intervista di Serafino Amato, con le parole di Sebastian Schaudhauser:
“Quando aveva finito una cosa, bruciava i manoscritti, non li lasciava, li bruciava” (video con testimonianza di S. Schaudhauser ripresa da Serafino Amato e conservato nel Fondo Alberto Moravia).
Era proprio quello il camino dove bruciava le sue bozze.
Mi giro, la donna è ormai seduta in prima fila, sul lato destro, davanti a un tavolo di cristallo. Appoggio il romanzo sulle mie ginocchia.
Io mi chiamo Alberto. Mi sarei presentato così a Moravia.
No, sarei rimasto a guardarlo, intontito.
Arrivano altre persone, e poi il gruppo di lettura prende forma, le presentazioni, sento sfogliare le prime pagine del libro, e Carola Susani al centro del lungo divano bianco legge il prologo. Ad alta voce.
Le pause, quelle virgole.
Tutta l’incompiutezza della persona è perfettamente contenuta nell’incipit, con una crepa, una piccola fessura che segnerà la memoria, il ricordo del giorno in cui Dino, il protagonista del romanzo, cessò di dipingere quando d’improvviso afferrò il coltellino radente di cui si serviva per raschiare i colori, e dilaniò la tela. A colpi ripetuti, sino a farne dei brandelli. Un gesto furioso per distruggere il lungo lavoro appeso a un cavalletto. Dino ripone un’altra tela, tutta bianca. Dove vuole arrivare Moravia? La noia aveva scandito il tempo, accompagnato tutta la produzione creativa di Dino in quella vecchia tela e doveva essere cancellata. Abbattere subito la realtà assordante, sconfiggerla, diventa l’imperativo categorico.
La tela segna un elemento estetico che disturba.
Un gesto non del tutto irrazionale, quello della distruzione. Scandisce improvvisamente un nuovo rapporto di Dino verso la sua opera, il rovesciamento dell’immaginario. E la rottura con il passato delinea tutto il senso di qualcosa che rimane incompiuto.
La non corrispondenza degli oggetti con il sé.
C’era una volta Alberto Moravia, lo scrittore più celebre e più intervistato d’Italia, scrisse una volta Antonio Debenedetti sulle pagine del Corriere della Sera.
Alla fine della seconda pagina inizia il dibattito nel gruppo di lettura. Qualche voce fioca, le spalle di alcuni che si muovono davanti a me, un colpo di tosse.
Perché Moravia.
Sarà un gesto rabbioso che spingerà Dino a confrontarsi realmente con il difficile rapporto materno, per sfuggire da quella donna che annienta la sua vita con il denaro.
“Mia madre, come sapevo, non credeva a niente, salvo che al denaro. Ma credeva, tuttavia, come ho già detto, a quello che lei chiamava: “la forma”; la quale, tra l’altro, imponeva di essere “praticante” e, comunque, di rispettare le cose della religione”.
La nuova tela sul cavalletto è carica di significati, di risultati. La noia diventa insufficienza, inadeguatezza, o scarsità della realtà circostante.
“Oppure, altro paragone, la mia noia rassomiglia all’interruzione frequente e misteriosa della corrente elettrica in una casa: un momento tutto è chiaro ed evidente, qui sono le poltrone, lì i divani, più in là gli armadi, le consolle, i quadri, i tendaggi, i tappeti, le finestre, le porte; un momento dopo non c’è più che buio e vuoto. Oppure, terzo paragone, la mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina; come a vedere in pochi secondi, per trasformazioni successive e rapidissime, un fiore passare dal boccio all’appassimento e alla polvere”.
La scrittura di Moravia già dal suo prologo dispone degli oggetti, siano finestre, porte, quadri, poltrone, un bicchiere, perché tutto contamina e tutto necessita di rappresentazione fisica, evoca una realtà incontrollabile nel confronto con l’inconscio.
La sintassi è alternata da virgole, vedo qua e là numerosi punti e virgola, usando come strumento l’avverbio “oppure” per legare le cose alle persone, per creare un termine di paragone con il sentimento.
Già, il famoso punto e virgola di Moravia.
È al posto del punto, è diverso, corrisponde a una scelta diversa. Lo ritrovo anche nel romanzo “Gli indifferenti”.
Non può passare inosservato. Anton Čechov sosteneva che in un periodo non è sufficiente porre correttamente i segni d’interpunzione. Bisogna inserirli consapevolmente, per mettere una virgola dobbiamo avere coscienza del perché viene segnata proprio lì, e non altrove.
Leggo ancora. Ho subito l’impressione che Moravia usi la virgola come enfasi, sottolinea, divide, fa pensare. Ma cosa separa?
La virgola che dovrebbe separare diventa una calamita.
Vado avanti, velocemente, mentre scorre la lettura ad alta voce. Rubo il tempo, e scopro che quel segno separa proprio per restituire una carica emotiva, distaccando il personaggio principale dagli altri.
Lo stesso Moravia per “Gli indifferenti” disse che ogni frase veniva fuori con la proprietà ritmica e solitaria di un verso.
Ritorno sul punto e virgola, perché ormai è stato quasi abolito dalla narrativa. Lo scrittore contemporaneo usa il punto fisso per far sobbalzare il lettore da un angolo all’altro. Sembra un diesel spompato, che va a singhiozzo, mentre nell’incipit del romanzo “Gli indifferenti” Moravia utilizza ben quattro volte il punto e virgola.
Sento le parole di Carola Susani che mi riportano al contenuto del libro, alzo gli occhi per un attimo e vedo tutti ancora con la testa china, a leggere.
Sin dalla descrizione iniziale si assiste all’uso del romanzo come innesto di elementi di saggistica, delineando un transfert: la malattia degli oggetti si trasferisce nell’uomo, una corporeità umana che viene accostata a quella fisica.
C’è qui tutta la macchina della preparazione narrativa di Moravia che si fa sentire.
Un tamburo, colpo su colpo.
Nella vita del protagonista entra poi Cecilia. L’ingresso nel romanzo della giovane ragazza è scandito nel momento stesso in cui Dino decide di abbandonare l’idea di fare il pittore.
Cecilia era l’amante del pittore Mauro Balestrieri, suo vicino di casa.
Una sottile perfidia nel dimostrare che Dino è subalterno al grande pittore.
Chissà quanto ghignava Moravia quando ha avuto questo guizzo narrativo.
Continuiamo la lettura dei capitoli con le riunioni pomeridiane e s’intuisce come la borghesia ricca venga fatta a pezzi, minuziosamente.
Il sesso nel letto della madre, dove Dino copre Cecilia con le banconote.
Dino vuole fuggire dalla sua condizione di figlio agiato, ma non ci riuscirà.
Non può distaccarsi dal mondo materno.
Entra in gioco il conflitto esistenziale con tutte le donne della sua vita.
Dino cerca di comprare Cecilia quando scopre che lei ha un altro uomo.
Inizia l’ossessione, il malessere accresce, la noia s’incunea nelle profondità delle viscere.
Un’ossessione da cui liberarsi, cercando una via di fuga e uno strumento.
Dino crederà di trovarlo nella passione carnale. I corpi che si sfiorano e l’abbandono della casa materna di via Appia, per trasferirsi in un piccolo studio di via Margutta, saranno il teatro della vicenda amorosa.
Mi giro verso la finestra, sono più vicino al terrazzo questa volta, lontano dal divano centrale. Le sedie scricchiolano, siamo tutti distratti dal ticchettio delle gocce d’acqua che si scaraventano sul vetro delle finestre. Le foglie degli alberi si muovono per il vento, ondeggiando. Le vedo alzando la testa verso la strada.
Entrando nel portone questa volta non c’era neanche l’ombra di una nube.
Chissà se c’era noia anche in quel ragazzo riccioluto dalla pelle olivastra che ha iniziato a comporre musica in un autobus, infischiandosene di tutti. Aveva afferrato tutto il suo mondo catapultandolo lì dentro.
“Rileggiamo insieme la descrizione che Dino fa di Cecilia”, dice Carola Susani.
Apro il libro, ma vado già a memoria.
Una rappresentazione minimalista, corporea e distruttiva allo stesso tempo:
“adolescente dalla vita in su, donna dalla vita in giù, Cecilia suggeriva un po’ l’idea di quei mostri decorativi che sono dipinti negli affreschi antichi: specie di sfingi o arpie, dal busto impubere innestato, con effetto grottesco, in un ventre e due gambe possenti”.
Dino si sente superiore.
Ma non è solo questo.
C’è un’attrazione fisica verso la donna che è impossibile dominare.
E ritorna in Moravia la pittura come elemento descrittivo, fenomenologico.
Il mondo di Alberto Moravia è contaminato dal dinamismo delle immagini, dalla volumetria.
Sarà proprio Alberto Moravia a evidenziare una traccia significativa di tutto ciò, quando, ormai sessantottenne, viene intervistato da Dacia Mariani (“Il bambino Alberto”, Milano, Bompiani, 1986), e finisce per legare lì il suo ruolo di romanziere con la pittura, tra i ricordi di quei quadri scuri della sua vecchia abitazione di Via Donizetti e le pareti del Villino Carovigno dei soggiorni estivi a Viareggio:
“Era tappezzato di enormi quadri del Seicento. Io passavo ore a guardarli. Fantasticavo su soggetti mitologici: i fauni, le ninfe. Non so perché non ho fatto il pittore. La pittura mi è sempre piaciuta più della letteratura”.
L’incrocio evidente tra letteratura e pittura diventa dentro “La noia” il segnale del percorso di sperimentazione. La contaminazione progressiva è tutta verso una dimensione di “scrittore d’arte”.
In un articolo pubblicato nel 1942 a proposito del pittore romano Giuseppe Capogrossi, trovo la conferma proprio quando lo stesso Moravia, sotto il nome “Pseudo”, indica come manifesto programmatico la comunione fra le due arti:
“Spesso avviene che pittori chiedano a scrittori di parlare delle loro opere. È questo un aspetto simpatico dei rapporti tra le varie arti, lo scrittore per tutti gli altri artisti è pur sempre il padrone della parola, questo mezzo espressivo che sa dipingere, scolpire, diventa musica e gesto e pur tuttavia rimane verbo. I pittori tra di loro, appaiono, a chi li osservi, pieni di accorgimenti e di furbizie, e forse lo sono anche con gli scrittori, ma con questi ultimi accorgimenti e furbizie si rivelano ingenui, proprio come quelli di un manuale di fronte all’uomo di scienza. In compenso la loro arte esercita sulla letteratura un’influenza molto maggiore di quanto non appaia a prima vista. Più ineffabile della scrittura per cui non è sempre pecca l’intellettualismo, essa fomenta nello scrittore il gusto per l’immagine e per l’analogia. Caduto il moralismo classico, la letteratura moderna, specie quella decadente e post-decadente, cerca di rivalizzare con la pittura in suggestioni plastiche lontane da ogni dialettica. Si pensi a Baudelaire si pensi, ai giorni nostri, a Cecchi. D’altronde, l’amore per la bellezza, che è quasi sempre amore per le immagini, si trova spesso più appagato da un quadro che da una bella pagina. […] Certi nudi, certe figure, certi paesaggi attirano l’uomo in un mondo di analogie profonde, la comprensione delle quali spesso non è affidata ai poteri razionali” (cfr., Pseudo, (Alberto Moravia), “Giuseppe Capogrossi”, in “Maestrale”, III, 12, 1942, p.19).
Moravia era stato presente anche alle iniziative della Galleria della Cometa nel 1935, un’officina artistico - letteraria voluta dalla contessa Mimì Pecci Blunt e diretta dal poeta Libero De Libero, che poi venne chiusa perché considerata contraria al regime fascista.
Moravia ricorre alle categorie della psicanalisi per accostare dentro “La noia” letteratura e arte pittorica.
Ritorno varie volte a casa Moravia, vedo documentari, testimonianze sullo schermo di quella tv messa al centro del salone, riascolto le sue parole, quelle della sorella pittrice, di Dacia Maraini, Enzo Siciliano, di Suso Cecchi, della nipote Gianna Cimino, Elio Pecora, Carlo Lizzani, Citto Maselli e molti altri compagni di vita, tutti lì, nella Roma di Moravia.
Mi assento nuovamente mentre Carola Susani chiede ad altri le impressioni su un capitolo assegnato in lettura.
Pasolini e Moravia.
L’orazione funebre.
“Qualsiasi società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue file. Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe esser sacro”.
Pasolini aveva avuto Moravia a ricordarlo.
Ero di nuovo tornato sullo stesso autobus del ragazzo riccio, senza riuscire però questa volta a sedermi per quanto era affollato. Nessuno con un libro in mano, e io, aggrappato a un manubrio.
Chi legge Moravia oggi, tra le nuove generazioni?
Siamo dentro un’era isterica, dove la ricerca di una lingua narrativa sembra contenuta in frammenti, strutture comunicative veloci, fuori dal ritmo di un romanzo classico. Già, il ritmo.
Tutto scivola tra i brevi messaggi di un telefono cellulare, semplici battute scambiate sui social network. Incollati a questi telefoni, uno in fila all’altro anche sull’autobus. Manca la reazione, lo strappo violento. Eppure, senza memoria non c’è futuro.
Sì, dobbiamo ricreare le condizioni di una memoria globale, uccidere il paradosso di vivere in mondo che definiamo “globale”, andare oltre la successione sincopata di uno storytelling virtuale.
È tutto finto. Siamo caduti in una trappola.
Moravia è l’alternativa, un rapido rifugio.
Ci vuole un atto di disobbedienza. Ora e subito.
Tutto in questo libro sembra riportare all’idea di un’impotenza delle parole di fronte all’arte, a quei quadri, a quella tela sfregiata nel prologo del romanzo.
C’è qui la condizione di subalternità dell’uomo alla pittura, come mondo di un’arte superiore, contemplativa.
Il fallimento della parola porterà al fallimento della relazione con Cecilia, e Dino, alla guida della sua automobile, devia all’improvviso dal percorso, si schianta contro un platano.
“non pensavo di uccidermi, l’idea del suicidio non era mai nella mia mente” (…) Esisteva, però, nel suo “corpo” la “voglia della morte”.
“Quello che in mancanza di termini più appropriati dovevo chiamare il mio suicidio, non aveva risolto niente; ma averlo tentato, se non altro, mi faceva pensare che avevo fatto quanto era in mio potere”.
La via del suicidio è seduttiva, “tentazione di una singolare irresistibilità, allettante e al tempo stesso rassicurante”, e attraversa l’irrefrenabile istinto di morte dei personaggi moraviani. Rivela tutta la loro insoddisfazione della vita.
L’impossibilità di liberarsi dalla sua condizione borghese è per Dino il ritorno ossessivo alla noia, e il definitivo fallimento:
“non si poteva rinunciare alla propria ricchezza; essere ricchi era come avere gli occhi azzurri o il naso aquilino”.
Inizia dentro il gruppo di lettura a sentirsi la voce isolata di una persona, una voce contraria.
E proprio lì lo studio della parola diventa più interessante.
Carola Susani lo pungola.
La contestazione libera un altro versante.
Le parole di questo romanzo ruzzolano giù comunque, arrivano a cucire diversi periodi storici passando per l’infanzia di Moravia. Rappresentano la sintesi, sono funzionali a ricostruire le fonti letterarie ancorate a un periodo preciso della sua giovinezza e alla stessa stesura del primo romanzo, “Gli Indifferenti”.
In una lettera senza data, ma post 23 novembre - dicembre 1926, spedita da Moravia a Umberto Morra di Lavriano e firmata con “Al. Pincherle”, contenuta nel volume “Se è questa la giovinezza vorrei che passasse presto” - Lettere [1926-1940], Bompiani, 2015, p.7, a cura di Alessandra Grandelis, Moravia già accennava alla noia:
“Mi annoio molto e ho un furioso desiderio di fare qualche pazzia – ma qualche pazzia di stile mio, novecentesco, moderno, non una delle stupidaggini borghesi – intanto ho trovato tutto più facile dell’ultima volta che venni a Roma, tutto più sereno e in compenso più immoto e questo mi dà – che io sia già immerso in quella vita insensibile e incomprensiva, cristallizzata, meccanica in cui si affonda senza accorgersene attraverso un sempre più grande e superficiale godimento e una sofferenza sempre minore? In tal caso sarebbe giunto veramente il momento di lasciare la letteratura (che non può riflettere che un movimento uno sviluppo: non una stasi)” e di farmi commerciante, importatore di patate, esportatore di fischi per capo stazioni o qualche cosa di simile – scrivere per mestiere ossia per altre persone è inutile-.”
È chiaro che la noia sarà un elemento costante in tutta la sua produzione letteraria, il contenitore di una struttura narrativa complessa, l’archetipo letterario.
Perché leggere Moravia.
E, allora, mi ritorna in mente un particolare che avevo già avvertito: ad alta voce tutto suona armonicamente. Ogni virgola divide e attrae.
Seduto sul divano mi ritrovo a rileggere a bassa voce un brano del libro mentre gli altri discutono, puntando alcune righe con un dito.
Sembra che ogni parola sia stata scritta per essere ascoltata.
È teatro. Moravia ha creato un romanzo a metà tra narrativa e saggio filosofico riuscendo a mettere in scena uno spettacolo teatrale.
È un preciso registro narrativo, complesso, dove i personaggi si muovono in uno spazio ristretto mimando una realtà in perenne conflitto che si muove e sposta sempre in avanti la scena.
Cecilia finirà per incarnare l’indifferenza.
Quindi, perché Moravia?
Per il ritmo teatrale del romanzo.
C’è fusione perfetta, sincronica tra tecnica narrativa e teatro che racchiude all’unisono Molière, Céchov, Shakespeare e Goldoni. Si sente tutta la maturità dello scrittore che ha assorbito Dostoevskij.
E il suo teatro diventa luogo abitato, quell’unico spazio dove l’uomo sceglie di interrogarsi sui grandi tempi esistenziali.
Lo spazio di movimento è minimo, ma quel minimo diventa mondo.
Moravia fa dell’oralità, dell’ascolto delle sue parole, la parte filologica più significativa.
Rende perfettamente nitida la visione.
Poi mi ricordo che Moravia in un’intervista disse che aggiungeva la punteggiatura solo dopo aver letto i brani ad alta voce.
È una tecnica.
Alzo lo sguardo e mi accorgo che le otto maschere africane poste sopra il divano del salone formano una lettera, la “U”, e sono tutte diverse.
O forse sono dei punti. E ogni punto è un periodo, una frase. Una storia a sé.
Chissà cosa guardava Moravia quando inseriva quei punti, se si alzava dalla sua sedia e girava per casa, concentrato sul segno d’interpunzione.
Quelle maschere segnano i confini sintattici del romanzo. E non esiste sempre una perfetta corrispondenza tra un punto all’altro, tra un punto e virgola e un punto, perché tutto deve variare, deve essere ricombinato, mescolato, per arrivare al senso finito dell’opera.
Sta qui la forza creativa, tutti i punti sono diversi come tutte le maschere sono diverse, anche se vicine.
E il lettore, a seconda di come legge un brano, scopre un senso diverso, dove un punto tende a invadere il campo degli altri segni, oppure isola, finisce, conclude. Morava ha messo la punteggiatura, l’ha interposta tra una parola e l’altra creando la visione teatrale nel romanzo.
Stramente alla fine di una frase nella pagina che ho di fronte mi torna in mente quel ragazzo dell’autobus. Il punto messo da Moravia era come la fine della strofa musicale.
E, di nuovo, perché Moravia.
Chissà se Moravia sorrideva quando concludeva una frase decisiva, lui così serio.
Lui che pensava così tanto a Dostoevskij tanto che scrisse:
“L’idea astratta della tragedia ha funzionato da detonatore per la mia inconscia, esplosiva conoscenza della vita familiare”, dirà così Moravia (A. Moravia, Breve autobiografia letteraria, in Opere 1927-1947, a cura di Geno Pampaloni, Bompiani, Milano 1986, p.VIII).
L’idea astratta della noia ha creato il dramma familiare.
E quest’idea astratta ha ridotto al minimo l’azione per dare spazio alla conoscenza.
Dino entra in conflitto con il pittore Balestrieri proprio quando conosce meglio Cecilia, donna sfuggente, fa paragoni continui, tornando sui passi della loro relazione, che ora crea un altro sentimento forte, oltre la noia. È la gelosia.
Cecilia sfugge alle domande, si allontana da Dino come a lanciare un segno di distacco dalla realtà storica, demolendo ogni ricerca di significato che Dino insegue per interpretare il comportamento della donna.
L’alienazione è solo dell’uomo, Cecila non ne rimane colpita.
Ottiero Ottieri, nella sua opera “L’irrealtà quotidiana”, Milano Guanda, 2004, p. 64, scriverà che
“Il sentimento sincero, sofferto di Dino è un’alienazione economica, la quale vissuta soggettivamente sviluppa sentimento d’irrealtà (ossia, la noia che ne è una variante ottocentesca)”.
Ma sarà proprio Moravia a descrivere esattamente quell’alienazione di Dino, in “I miei problemi”, pubblicato su L’Espresso, 26 maggio 1962 e anche in “Alberto Moravia. L’uomo come fine e altri saggi”, pp. 377-378, scritto nel 1946 e pubblicato nel 1954 su “Nuovi Argomenti”, e poi con la Bompiani, Milano, 1964,
“c’è alienazione ogni volta che l’uomo è adoperato come mezzo per raggiungere un fine che non è l’uomo stesso bensì qualche feticcio che può essere via via il denaro, il successo, il potere, l’efficienza, la produttività e via dicendo”.
Moravia fa sentire il suo interesse per la struttura del romanzo, spingendo con la prima persona ad approfondire temi esistenziali.
Montale aveva centrato un punto fondamentale nel suo articolo del 24 novembre 1960 uscito sul Corriere della Sera, “(…) il solo romanzo che possa interessare è il romanzo scritto in prima persona, il solo che possa includere «una dimensione saggistica». In prima persona sarebbe scritta anche la pittura astratta”.
E, allora, cerco frammenti autobiografici che diano spiegazione alla matrice di questo romanzo, alle scelte strutturali, trovando un dettaglio qui, nell’intervista fiume che gli fece Alain Elkann:
«Una seconda crisi [di scrittore] […] l’ebbi tra La ciociara e La noia. […] Suppongo che fosse dovuta al crollo del mito nazionalpopolare che mi aveva fatto scrivere La romana, La ciociara e I racconti romani. O meglio, non fu un crollo, visto che poi ho continuato a scrivere e a pubblicare. Fu soltanto il venir meno dell’energia creativa che è insita in ogni mito. Rimasi fedele alle idee politiche di sinistra che avevo sempre avuto, ma non me la sentivo di scrivere romanzi e racconti del genere di quelli che avevo scritto nel dopoguerra. Forse questa crisi fu più profonda di quanto non mi sembra adesso. Tanto è vero che ne uscì La noia, un romanzo che può parere una soluzione di continuità rispetto ai romanzi e ai racconti del mito nazionalpopolare. Ma non era così. In realtà così la noia descritta nel romanzo omonimo come l’indifferenza degli Indifferenti stavano pur sempre ad indicare quell’angoscia di vivere che sono convinto sia alla base della corrente esistenzialistica a cui so di appartenere e dalla quale secondo me deriva in gran parte il romanzo contemporaneo. Detto questo, vorrei soltanto aggiungere che la noia non è un argomento nuovo nella letteratura moderna dall’Ottocento ad oggi. Basterà ricordare le pagine famose di Schopenhauer, nonché lo spleen dei decadenti» (cfr. ALBERTO MORAVIA, ALAIN ELKANN, Vita di Moravia, Milano, Bompiani, 2007, pp. 191-192).
Accedo alle stanze del Fondo Moravia per consultare l’archivio imponente di cui c’è una precisa traccia anche in un articolo di Gabriella Nisticò apparso su “Nuovi Argomenti” (71- Luglio-Settembre 2015, p.191). Proprio in quelle stanze viene conservato il carteggio con Valentino Bompiani, i materiali scritti con la macchina dattilografica, i manoscritti a cui Moravia ha lavorato, alcune tracce degli originali altre in copia carbone, verbali, correzioni e integrazioni di varie opere.
La datazione cronica delle opere in archivio è stata fatta anche lavorando con il criterio della presunzione, tramite fonti orali e sue interviste.
Ritorno a casa Moravia a fine lettura del romanzo. Questa volta c’è Dacia Maraini con Eugenio Murrali, che raccontano alcuni momenti vissuti dallo scrittore dentro il teatro.
Moravia, infatti, aveva costituito “Il teatro del Porcospino” nell’ottobre del 1966 in una cantina romana a via Belsiana, assieme a Dacia Maraini, Enzo Siciliano, Paolo Bonacelli, Carlotta Barilli, Carlo Montagna, e Roberto Guicciardini.
“Un teatro che doveva pungere”, come lui stesso disse descrivendo quella fase dell’avanguardia teatrale romana dove furono messi in scena, oltre ai loro testi, quelli di Wilcock, Parise, Ottieri, Malerba, in polemica sia con il teatro gestuale che con quello di regia.
È il 21 giugno di quest’anno quando assisto alla lettura scenica dell’opera teatrale di Moravia, “L’intervista”, commedia in un atto a cura di Riccardo Caporossi.
Siamo nel salone del quinto piano di Lungotevere della Vittoria, tutti seduti in cerchio quando tra il pizzicore della polvere dei libri fa ingresso una giovane attrice. Ha gli occhi a mandorla, scuri, puntati sul centro dal salotto, la mano sinistra inarcata, leggermente distante dal corpo, le labbra serrate, e il collo leggermente curvo.
Scorro la locandina che ho tra le mani e leggo il nome dei due attori.
Dopo pochi istanti cessa il brusio.
Silenzio, si va in scena.
Entrò Moravia, lì, tra noi. Ancora una volta. |
.gif)